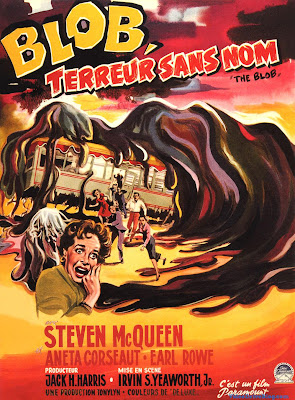
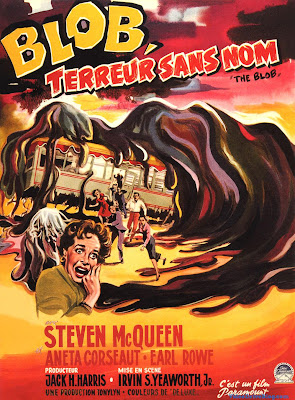
Le trasformazioni di Roma Fame da Lupa
Autore: Bertamini, Fulvio Data di pubblicazione: 02.12.2010 Fonte http://www.eddyburg.it/article/articleview/16278/0/3)9/
«Il prg 2008 è nel cassetto, mentre si pensa a sviluppare l’housing in nuove aree. Azzannando ancora l’Agro». Un ampio resoconto su Costruire, novembre 2010
Il nuovo piano regolatore? Nato moribondo dopo 15 anni di gestazione e
approvato dal consiglio comunale nel febbraio 2008, solo due mesi prima
dell’avvento dell’era Alemanno, reso instabile dalle lotte intestine alle
maggioranze di centrosinistra che l’avevano elaborato – le due giunte di Rutelli
e le due Veltroni (1993-2008) – ha ormai l’encefalogramma piatto. Alcuni suoi
organi – l’impianto normativo e il sistema perequativo – sono già stati
espiantati, il resto probabilmente verrà sepolto in un cassetto. Sono altri gli
sviluppi che interessano il futuro di Roma, che galleggia fra le visioni
elettorali di Alemanno – il piccone risanatore nelle periferie pubbliche del
Corviale o di Tor Bella Monaca, la voglia di grattacieli – e molto più concrete
occasioni di business, come il progetto della Formula 1 all’Eur, la candidatura
per le Olimpiadi del 2020, il ridisegno del waterfront di Ostia.
Nel presente, il problema più serio è la questione abitativa, a Roma vero e
proprio nodo urbano. La capitale conosce fenomeni d’altri tempi: continua a
macinare residenze (in media 10 mila all’anno) accumulando forti quote di sfitto
e invenduto, mentre 2 mila famiglie vivono in abitazioni occupate. Il centro
storico e la città consolidata, del primo Novecento, perdono abitanti (300 mila
negli ultimi dieci anni), mentre ingrassano i comuni di prima, seconda e terza
cintura, ben oltre il Raccordo anulare, al punto che c’è chi parla ormai di
periferia regionale. Sul suo territorio sterminato – 129 mila ettari, dieci
volte l’estensione di Milano – insistono 114 quartieri di edilizia pubblica dove
vivono 600 mila abitanti, nati anche per sanare la prevalente periferia abusiva.
Ovunque i servizi sono carenti. Nello sprawl urbano favorito dalla presenza
dell’Agro, grande riserva di aree, oltre che di archeologia e natura, anche il
traffico rappresenta “una patologia urbanistica”, come spiega Walter Tocci,
vicesindaco e assessore alla Mobilità nelle giunte Rutelli (1993-2001). Nel bel
libro “Avanti c’è posto” (Donzelli editore) Tocci scrive: “Se analizziamo, ad
esempio, le strade bloccate regolarmente tutte le mattine, come la Cassia o la
Prenestina, constatiamo flussi di traffico non impossibili, poco sopra le 1.000
auto/ora, alla portata di autobus capienti e frequenti. Se in quelle condizioni
si arriva alla saturazione significa che non è un problema di quantità, ma di
cattiva disposizione degli elementi nello spazio”. Inevitabile in una città dove
– ricorda sempre Tocci – l’abusivismo è stato “il vettore della grande
espansione novecentesca, […] il catalizzatore dei processi, la forza propulsiva
che va oltre le prime borgate pubbliche, oltre i confini del piano del 1931 e di
quelli del 1962, che travolge […] il tentativo di contenimento della cosiddetta
ricucitura degli anni Ottanta, fino a contaminare l’ultimo piano del Duemila”.
Ma a chi importa davvero sistemare questo blob edilizio a bassissima densità? La
classe imprenditoriale, costruttori compresi, cura legittimamente i propri
interessi, ad ampio spettro per pochi grandi (come Francesco Gaetano Caltagirone,
affaccendato in partecipazioni bancarie, giornali, muncipalizzate), di medio o
piccolo cabotaggio per quasi tutti gli altri. E l’amministrazione pubblica,
tendenzialmente, si adegua. “In Italia, e anche a Roma, ha sempre inseguito gli
interessi privati. Meglio: li ha sempre assecondati, ricevendone una risposta
funzionale alla propria sopravvivenza. Questi sono i rapporti di forza in
campo”. Parole condivisibili e un po’ sorprendenti, visto che a pronunciarle è
l’attuale assessore comunale all’Urbanistica Marco Corsini, un tecnico che
conosce bene i meccanismi della politica: “Nelle grandi città le scelte
urbanistiche fondamentali sono compiute dal sindaco, con cui si relazionano i
grandi poteri. L’assessore è solo un attuatore, a Roma come a Venezia”, dove
Corsini è stato assessore ai Lavori pubblici della giunta Costa. Sarà per questo
che Alemanno è sommerso da visioni così irraggiungibili? Fra i suoi sogni pare
esserci anche l’eredità politica di Silvio Berlusconi. In fondo, ci hanno
provato anche Francesco Rutelli (2001) e Walter Veltroni (2008) a sfruttare il
Campidoglio per tentare l’assalto a Palazzo Chigi, interrompendo con le
rispettive legislature processi molto importanti: per esempio l’approvazione del
prg, che come ricorda Domenico Cecchini, assessore all’Urbanistica di Rutelli,
poteva essere varato comodamente entro la scadenza naturale del mandato, nel
2003. Perché se è vero che l’urbanistica è politica, nella capitale della
politica italiana questo è vero due volte: una iattura, per la città e anche per
i candidati premier (sempre perdenti). Alemanno ci pensi: la maledizione della
Lupa incombe.
Ma c’è un’altra partita politica molto importante in corso, quella per Roma
Capitale. Dopo l’approvazione del primo decreto legislativo la città ha
ufficialmente acquisito un nuovo status giuridico. Ma sarà il prossimo dlgs, se
mai vedrà la luce, a portare in dote la ciccia, ovvero le nuove competenze di
scala metropolitana: sacrosante, date le dimensioni territoriali in gioco. In
palio c’è probabilmente troppo, compresa la funzione urbanistica (che la
Costituzione affida alle Regioni) e la valorizzazione paesistica e dei beni
culturali. Se l’operazione andasse in porto cambierebbe il peso di Provincia e
Regione, che rischiano di trasformarsi, rispettivamente, in un ente di
testimonianza e “in un buco con un po’ di territorio intorno”, come afferma
efficacemente l’urbanista Vezio De Lucia. Dire che i presidenti Zingaretti e
Polverini siano contrari all’ipotesi è un eufemismo. Volano coltelli anche a
mezzo stampa e viene sollevata l’ipotesi (non infondata) di incostituzionalità
della norma. E qui torniamo alla domanda iniziale: chi ha cuore davvero le
magagne di Roma? A chi interessa la gestione efficiente del suo malconcio
territorio? La sensazione è che la speculazione edilizia non sia la peggiore
delle malattie. La speculazione politica è pure peggio.
Adagio con il piano
La struttura del prg è costruita su tre elementi cardine. Anzitutto la
cosiddetta cura del ferro, basata su un accordo di programma fra Comune,
Provincia, Regione e Fs, che prevede “la la prosecuzione delle attuali linee
metropolitane A e B – ricorda il presidente dell’Inu Federico Oliva, uno dei
superconsulenti del piano – l’introduzione di due nuove linee, C e D, e tre
passanti ferroviari di superficie che utilizzino la rete esistente di Rfi. Il
tutto articolato sulla cintura ferroviaria, che a Roma è poco più ampia delle
mura aureliane e ancora incompleta nella parte nord”. Gli enti coinvolti si sono
impegnati a finanziare un’operazione da 12 miliardi di euro, in grado di servire
la metà dei cittadini. Seconda gamba del piano, il nuovo sistema del verde: la
rete ecologica, formata da parchi, aree naturali e territori agricoli, “copre il
68 per cento del territorio romano”, spiega Domenico Cecchini, che diede impulso
alla prima fase del prg. Terza gamba: il policentrismo. Accantonata l’idea di
Luigi Piccinato, che nel piano del 1962-65, per decongestionare il centro
storico, aveva disegnato lo Sdo, sistema direzionale dell’area orientale ove
decentrare i ministeri, si privilegiò una nuova visione: “Si prese atto che il
territorio di Roma è metropolizzato – sostiene Oliva – caratterizzato da
insediamenti da 100-150 mila abitanti, vere e proprie città, e si pensò di
addensare sui nodi del ferro tutte le nuove previsioni, creando nove centralità:
alcune nuove, altre già esistenti, come Tor Vergata. Qui dovrebbero essere
realizzate non residenze, molto presenti nel contesto territoriale, ma funzioni
urbane di qualità e attività produttive”. Per centrare l’obiettivo si utilizza
lo strumento della perequazione/compensazione: vengono riconosciuti i diritti
edificatori maturati nel precedente prg, ma i proprietari sono chiamati a
esercitarli nelle nuove polarità o comunque a tiro di ferro. A questi si
aggiunge “una limitata previsione di nuova edificazione, pari a circa 400 mila
stanze”.
La scelta di riconoscere i diritti edificatori
del piano del 1962 scatena l’opposizione interna al centrosinistra, che non
fa che riverberare in chiave politica (l’asse Rifondazione-Verdi contro il resto
del centrosinistra) la spaccatura tecnica maturata all’inizio degli anni Novanta
all’interno dell’Istituto nazionale di urbanistica fra il gruppo di Federico
Oliva e Giuseppe Campos Venuti (altro padre del piano di Roma) e il gruppo Polis
(Edoardo Salzano, Vezio De Lucia, Paolo Berdini, fra gli altri). Il piano viene
accusato di determinare una nuova colata di cemento in città, “pari a 64 milioni
di metri cubi”, quantifica Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio.
Vezio De Lucia accusa il prg “di essere privo di qualunque elaborazione sul
dimensionamento, poiché a fronte di un incremento volumetrico complessivo pari a
circa il dieci per cento dell’esistente – tutto sommato ragionevole –
corrisponde un aumento del 35 per cento della superficie occupata”. E ricorda
che Italia Nostra, di cui è consigliere nazionale, incaricò l’avvocato
amministrativista Vincenzo Cerulli Irelli (“Un ex democristiano, non un
sovversivo”) di presentare un parere pro veritate in cui venne chiarito “un
principio che noi urbanisti di vecchia scuola conoscevamo già molto bene: l’edificabilità
è data dal piano e il piano la toglie, i diritti edificatori non esistono”.
Paolo Avarello, già presidente dell’Inu e docente di Urbanistica a Roma 3,
sottolinea che “il prg, che voleva essere uno strumento innovativo, ha ereditato
in effetti il passato”. Compreso il problema dei rentier “che hanno già pagato
le tasse sulla proprietà di terreni edificabili: tornare indietro sarebbe molto
difficile, oggi, così come espropriare”. Se non si riconoscono le previsioni
edificatorie pregresse, ragiona Avarello, c’è il rischio fondato di paralisi da
contenzioso.
In ogni caso, alla perequazione si affida il compito di realizzare il nuovo. Cui
bisogna aggiungere il cosiddetto contributo straordinario connesso al rilascio
del permesso di costruire: “Le norme tecniche del prg – sottolinea Cecchini –
prevedono che il plusvalore derivante dalle decisioni urbanistiche debba tornare
alla città attraverso una contribuzione straordinaria pari al 66 per cento”. La
norma era stata affossata dal Tar del Lazio, ma è stata ripescata il primo
settembre scorso da un pronunciamento del Consiglio di Stato. La decisione è
stata salutata con grande favore dall’assessore Corsini: il Comune, del resto,
aveva difeso in sede giudiziaria il prg. “Adesso vedremo se l’amministrazione
Alemanno avrà la forza di esigere il contributo straordinario”, chiosa uno
scettico Cecchini.
Ma che cosa vuol fare l’amministrazione capitolina del prg? Una fonte interna
che ci chiede l’anonimato conferma che sul tema centralità non si sta muovendo
foglia. Corsini ammette che si sta ragionando su un loro “ripensamento
funzionale”. Si consideri poi che il primo atto urbanistico della giunta
Alemanno, maturato subito dopo l’insediamento, è stato un bando per il
reperimento di nuove aree ove realizzare 30 mila alloggi di edilizia
residenziale, snobbata dal prg, almeno secondo il Campidoglio. Sono pervenute
300 proposte, “ma vi daremo seguito – afferma Corsini – solo dopo aver esperito
altri strumenti, dalla densificazione al recupero di superfici pubbliche
all’interno degli sviluppi urbanistici, dall’acquisto e vendita di immobili ai
cambi di destinazione d’uso. Perché non vogliamo consumare altro territorio.
Quel che manca sarà oggetto di una variante al prg, che verrà presentata forse
entro il 2011”.
Le politiche di Alemanno sull’housing sono contestate da Cecchini e da Daniel
Modigliani, alla guida dell’Ufficio di piano al momento dell’approvazione del
prg, che sottolineano come “trasformare aree agricole in edificabili serve solo
alla speculazione fondiaria, non a dare case a chi è effettivamente in
condizioni disagiate”. Perché il problema “non sono le aree, ma i finanziamenti
pubblici necessari a costruire le case sovvenzionate e a ridurre i prezzi delle
convenzionate”. In ogni caso, secondo Cecchini e Modigliani, basta dare corso ai
35 piani di zona già approvati e ad altre disposizioni del piano per realizzare
nei prossimi cinque anni “non meno di 10 mila alloggi in aree già previste come
edificabili dal prg”. Senza consumare altro Agro o attentare ulteriormente a
parchi intorno a Roma, fra cui quello dell’Appia Antica, che nei sogni del
giornalista e scrittore Antonio Cederna e dell’ex soprintendente ai Beni
archeologici Adriano La Regina avrebbe dovuto essere valorizzato e unito al
cuore della città eterna. Un progetto bellissimo e cancellato, con via dei Fori
imperiali oggi ridotta ad arteria di scorrimento viario verso l’ingorgo mefitico
di piazza Venezia. Ma questo è un altro discorso.
Tornando all’housing sociale, va tenuto presente che trattasi di tema sensibile.
È stato uno degli slogan forti della campagna elettorale di Alemanno: da qui
tanta fretta nell’approcciarlo. Del resto, dal mondo dei costruttori – con la
benedizione preelettorale di Francesco Gaetano Caltagirone, le cui rare parole
pesano come pietre – e dal popolo delle periferie sono venuti molti voti per il
sindaco. Il resto è poesia, o quasi. L’analisi di Corsini non lascia adito a
dubbi: “Condividiamo il sistema di regole del prg, non gli aspetti operativi. La
realtà corre ben più velocemente delle previsioni del piano, che è privo di una
visione strategica. Inoltre sono maturate altre riflessioni, che ci hanno
portato a investire sul waterfront di Ostia, sulla candidatura alle Olimpiadi
del 2020, sul riutilizzo delle aree che erediteremo con il federalismo
demaniale, sulla realizzazione dei nuovi stadi per Roma e Lazio, sulla pista di
F1 da realizzare all’Eur. E così il prg è entrato fisiologicamente in crisi il
giorno dopo l’approvazione”. Anche la cura del ferro sarà annacquata: “Nessuno
ha intenzione di fermare questo processo, data la sua tempistica per ere
geologiche”, continua Corsini. Ma nel frattempo, per cautelarsi, la giunta ha
presentato un nuovo piano della mobilità. Sostenibile, va da sé.
Consigli per gli acquisti
Archiviato il prg, si pensa ad altro. Secondo Paolo Berdini, docente di
Urbanistica all’Università Tor Vergata, “l’amministrazione comunale, attraverso
l’uso dell’emergenza legata ai grandi eventi, sta cercando di definire il nuovo
volto della città, depotenziando un piano che non condivide. E per centrare
l’obiettivo sta orientandosi su altri progetti”. Per esempio i nuovi stadi per
le squadre di calcio capitoline, veri e propri pezzi di città. Quello della
Lazio, per esempio, è un complesso polifunzionale di “seicento ettari, fuori dal
Raccordo anulare, al 90 per cento del costruttore Gianni Mezzaroma”, suocero del
proponente Claudio Lotito, in una zona – lungo la strada Tiberina, al confine
con il Comune di Fiano – che per “l’80 per cento fa parte dell’agro romano
vincolato” (da “La colata” di Garibaldi Massari Preve Salvaggiulo Sansa,
editrice Chiarelettere). Anche la location individuata per il villaggio olimpico
a Tor di Quinto, in un’area piena di vincoli, lascia perplessi. Passare da un
piano anche criticabile (e criticato) a una visione così puntiforme può sembrare
espressione di una visuale un po’ limitata, magari provinciale, almeno per una
grande città. Ma va considerato “che questa non è Milano – spiega Antonello
Sotgia, dello studio di architettura Marchini Sotgia – qui i grandi sogni che si
rincorrono sono soprattutto grandi slogan”. Qui nel dna ci sono borgatari e
palazzinari “e Alemanno ha compreso che la città con cui dover fare i conti è
questa, è fatta di allontanamenti forzati delle comunità rom e di
progetti/eventi capaci di apparecchiare e rendere possibili i soliti esercizi di
rendita”. E ora, con Roma Capitale “e i poteri assoluti che con questa legge
vorrebbe assumere”, il gioco potrebbe cambiare. “Veltroni era costretto a
rivolgersi al migliore offerente – continua Sotgia – prefigurando un piano
regolatore delle offerte in cui leggere le normative tecniche come consigli per
acquisti. Alemanno oggi, quando parla di abbattere case e palazzi, spostare
persone, ricostruire edifici secondo precisi modelli estensivi, non parla da
urbanista e neppure solo da sindaco, ma da nuovo ingegnere istituzionale”.
Nell’attesa dei nuovi poteri, “seduce le periferie giocando sul loro male di
vivere. E deve dare una risposta ai piccoli costruttori, che l’hanno sempre
appoggiato”. E che sono prodighi di suggerimenti su come intervenire nello
sprawl. La relazione che il presidente dell’Acer Eugenio Batelli ha presentato
nel corso dell’ultima assemblea dell’associazione dei costruttori romani, alla
fine di settembre, batte molto sul tema. Per esempio, negli “insediamenti nati
spontaneamente”, da Montespaccato a Vermicino, da Infernetto a Centocelle, è
consigliata la sostituzione edilizia, “ma gli incentivi attualmente previsti dal
piano casa regionale non garantiscono il necessario riequilibrio economico”.
Batelli chiede dunque un premio di almeno il 60 per cento della cubatura,
andando oltre le pur generose previsioni del piano Polverini, che sta ritoccando
la legge varata dalla giunta Marrazzo ma si ferma, nello specifico, al 50 per
cento. I costruttori sanno che tocca a loro colmare la “mancanza di risorse” che
ha impedito di mettere mano al problema periferie, anche perché in cassa il
Campidoglio ha soprattutto un mare di debiti: “Il Comune di Roma deve sostenere
fino al 2043 il piano di rientro dal dissesto finanziario”, sottolinea Batelli.
Sicché prova a dettare qualche condizione: “Negli interventi di edilizia
agevolata del secondo piano peep (edilizia economico-popolare, ndr) a
Castelverde, Torraccia/Casalmonastero e Muratella” si richiede di densificare i
piani “nelle aree extra standard non utilizzate”. Discorso analogo sia per i
piani di recupero urbano meglio noti come articoli 11, per i quali Batelli
propone “di riconsiderare le destinazioni d’uso non residenziali ormai superate,
reperendo così contributi straordinari necessari per il completamento delle
opere pubbliche”, sia per i print (piani di recupero integrato), per i quali
sollecita “premi di cubatura adeguati all’onerosità degli interventi”.
Nuove aree e nuovi incentivi per nuove case. Quanto al ridisegno dei grandi
complessi pubblici di stampo collettivista – come li ha definiti Alemanno –
Batelli non si azzarda: sa che l’impresa è titanica. “La riqualificazione delle
periferie non deve certo cominciare dai quartieri di edilizia residenziale
pubblica – afferma l’ambientalista Lorenzo Parlati – dove i problemi sono di
carattere sociale, non urbanistico. Meglio puntare sugli insediamenti abusivi”.
Lì c’è trippa per gatti: “Un terzo di Roma è sorto così. Oltretutto si tratta di
edilizia privata, in cui un intervento privato di riqualificazione, favorito
naturalmente da un piano comunale in grado di mantenere l’interesse pubblico
dell’operazione, potrebbe avere senso e dare risultati importanti”. Aggiunge il
presidente dell’Ordine degli architetti di Roma, Amedeo Schiattarella: “Sono
d’accordo con il principio di fondo: l’amministrazione deve poter demolire e
riabilitare intere parti di città. Il caso del quartiere Giustiniano Imperatore
– parzialmente ricostruito dopo gravi problemi di dissesto, ndr – dimostra che
l’operazione è complessa, ma si può fare. Coinvolgendo anche i privati,
naturalmente. Che però, nella fattispecie, devono essere portatori anche di
valori generali. Ci vuole un progetto serio, insomma, che può essere garantito
soltanto dallo strumento concorsuale”. Schiattarella chiede quindi l’avvio di
una stagione di concorsi, meglio se di progettazione, perché quelli di idee
“spesso restano nel cassetto”. E riferiti non solo al ridisegno delle periferie,
ma a tutti i futuri sviluppi della capitale. A cominciare dalla riconversione
delle aree ex demaniali. Ben consapevole che il passo, finora, è stato diverso,
con rari monumenti contemporanei – dal Maxxi di Zaha Hadid alla teca dell’Ara
Pacis di Richard Meier, che ora forse perderà il suo muretto – nel deserto
dell’architettura. Sullo sfondo, il mare di sprawl, di cui Roma è capitale. La
Lupa non ha ancora perso il vizio e finché c’è Agro, c’è speranza.
box 1 - Densificare, non consumare
Dal 2002 al 2008 la popolazione di Roma è cresciuta del 7 per cento e supera
i 2,7 milioni di abitanti, ma nello stesso periodo i residenti della Provincia,
esclusi quelli della capitale, sono aumentati del 17 per cento, mentre nella
cintura romana l’incremento ha raggiunto il 23 per cento. Elementi che
evidenziano “come la crescita di Roma ormai avvenga essenzialmente fuori dai
confini comunali”, soprattutto lungo la direttrice nord, grazie alla presenza
del collegamento ferroviario Fiumicino-Orte. “Roma cresce a Orte” è infatti il
titolo della prima di una serie di ricerche sviluppate in questi ultimi anni
dalla facoltà di Architettura dell’Università Roma tre, coordinate dal docente
di Progettazione urbanistica Giovanni Caudo. Un lavoro che fornisce una ricca
documentazione di dati e che consente di comprendere le dimensioni della
questione abitativa romana, “che intreccia dinamiche di complessità urbana”,
afferma Caudo. I numeri sono impietosi: a Roma gli sfratti sono numerosissimi
(uno ogni 220 famiglie nel periodo gennaio-dicembre 2008) ed è tornata di moda
la pratica delle occupazioni, che dal 2002 al 2008 hanno fornito una risposta
abitativa a 2.500 famiglie, mentre nello stesso periodo i numeri di alloggi di
edilizia economico-popolare assegnati dal Comune di Roma sono stati circa 1.700.
La risposta alla domanda abitativa resta dunque molto debole. La città si
sviluppa nelle periferie anche oltre il Gra, a cavallo del quale un milione
circa di romani ogni mattina si muove per raggiungere il centro della città. Un
inferno. Al quale però si può rimediare. Anche perché è possibile intervenire
con una densificazione edilizia mirata, anziché continuare nella pratica dello
sprawl. La capitale si è sviluppata a bassa densità: ogni abitante dispone di
230 metri quadrati di aree urbanizzate, un valore sei volte superiore a quello
di Parigi. Per invertire la tendenza, il gruppo di ricercatori di Roma tre ha
svolto un ragionamento sulle aree che insistono sull’attuale sistema di ferrovie
e metropolitane, ovvero sui nodi di scambio, compresi quelli in corso di
trasformazione. “E abbiamo scoperto – afferma Caudo – che nelle zone centrali
già oggi vi sono ettari di superficie sottoutilizzata, destinati magari a
ospitare solo parcheggi a raso”, come a Tordivalle. Le strategie elaborate
indirizzano in questi ambiti (11 in tutto) la localizzazione di residenze,
servizi, funzioni direzionali e amministrative: gli interventi di densificazione
consentirebbero di realizzare 7.800 alloggi e una superficie utile non
residenziale pari a 286 mila metri quadrati. Un altro ambito d’intervento
potrebbe essere il completamento del piano di edilizia economico-popolare di
Roma, il più grande d’Italia, che in 40 anni ha prodotto 114 piani di zona con
una dotazione di standard ancora insufficiente (-18% rispetto alle previsioni,
423 ettari in tutto). “Si tratta di una quota importante del territorio comunale
– afferma Caudo –composta da centinaia di aree, di scarto e di interstizi, che
ricadono nel perimetro dei singoli piani di zona, molti dei quali all’interno
del Gra, già raggiunti dalle infrastrutture e dalle opere di urbanizzazione. Una
dote che l’amministrazione comunale potrebbe considerare per la formulazione di
un nuovo progetto per la città”. Anziché consumare nuovo suolo.
box 2 - cittadinanza attiva
Capire “che la città non esiste più, che è esplosa, ha perso il suo tessuto
di relazioni sociali”. Ma anche comprendere “quale altri spazi si vanno creando,
quali nuove realtà genera l’impatto urbano su paesaggi storici, agricoli, in
contesti marginali, in villaggi che non conoscevano la metropoli”. Lorenzo
Romito è un progettista dell’associazione Stalker, realtà che da sempre coniuga
architettura e sociale, in passato molto impegnata in lavori nei campi rom e al
Corviale. Racconta un percorso molto interessante, che da uno spunto conoscitivo
legato alle mille periferie di Roma sta sviluppando un percorso di aggregazione
e cittadinanza attiva. “Il nostro primo tentativo è stata l’esplorazione di
Campagna romana. Abbiamo formato otto gruppi, nei quali erano sempre presenti un
urbanista, un fotografo e uno scrittore, e abbiamo percorso a piedi le
principali direzioni regionali: cinque giorni di marcia per intercettare i
processi che produce quella che ho definito l’Oltrecittà. Parlare di città oggi
significa fare riferimento a una dinamica di relazioni centro-periferia che mi
pare superata. Mi sembra che stia emergendo qualcosa di nuovo e cercare di
capirlo può forse significare la possibilità di indirizzare lo sviluppo. Se si
riesce a visualizzare questa trasformazione e se gli abitanti riescono a
coglierla, forse da loro stessi possono venire spunti, pratiche, idee per
rovesciare le dinamiche attuali”. Chi ha detto che la periferia è solo
marginale, ragiona Romito. E lo dimostra con una seconda esperienza, Primavera
romana (2009): ancora una lunga camminata, stavolta attorno al Raccordo anulare,
accompagnata dall’esplorazione di tutte le realtà presenti, “dai campi rom agli
orti urbani, dai comitati di quartiere che lottano contro la speculazione
edilizia alle occupazioni”. L’esplorazione ha dato origine a una mappatura e la
cartografia è stata messa online, a disposizione di tutti. Primavera romana è
stata replicata quest’anno successivo: la ricerca questa volta si è concentrata
in quelle che vengono definite le sette città fuori porta, ovvero “nelle
periferie consolidate – Prenestino-Casilina, Ostiense, Trionfale, il Salario, il
Nomentano, il Tiburtino – che ormai, con la musealizzazione del centro, sono
l’unico residuo di città esistente, dove ci sono dialogo, confronto, conflitto
sociale”. Qui è forte il tema del riuso delle grandi strutture pubbliche
abbandonate, “dal mattatoio agli ospedali – continua Romito – spazi centrali
attorno ai quali si sono formate le sette città e che sarebbero il luogo da cui
ripartire per ridisegnare questi ambiti, sottraendoli alla speculazione futura o
all’oblio. Reinventarsi un’articolazione dei luoghi, riferendosi alle comunità
esistenti e alle problematiche comuni, è un modo per visualizzare un disegno
amministrativo della città”. Un tema forte, tenuto ancora sottotraccia perché il
punto per Romito “non è esprimere idee e visioni, ma condividere la
consapevolezza dei problemi, assecondando un passo più lento, che però produce
maggiore coinvolgimento e partecipazione attiva”. Da qui nasce, il mese scorso,
l’ultima iniziativa, l’autoconvocazione degli Stati generali della cittadinanza,
che nasce “per mettere assieme comitati e movimenti, aggregando esperienze
importanti ma spesso autoreferenziali, condividendo pratiche, facendo
comprendere l’interdipendenza dei problemi”. Una sorta di rete che, se riuscirà
a formarsi, è destinata a diventare un soggetto politico attivo, sulla scia
delle esperienze maturate in altre città (a Venezia per esempio, vedi Costruire
n. 326). “Roma nasce in un luogo di passaggio lungo il Tevere – afferma Romito –
come aggregazione di villaggi che stringono un patto di cittadinanza per
trasformare un’area conflittuale in uno spazio condiviso. Se la città non
ritroverà questa sua marginalità strutturale e continuerà a vivere di rendita,
propagandando l’idea imperiale e un po’ fascista di centro, è destinata a
perdere forza e identità”.
A proposito dei ”Diritti edificatori" vedi il parere pro veritate di
Vincenzo Cerulli Irelli e il documento "Forse che il diritto impone di
compensare i vincoli sul territorio?" di
Edoardo Salzano.
ARGOMENTO COLLEGATO:
http://www.ciardullidomenico.it/OTTAVIA/urbano_palmar_selva.htm